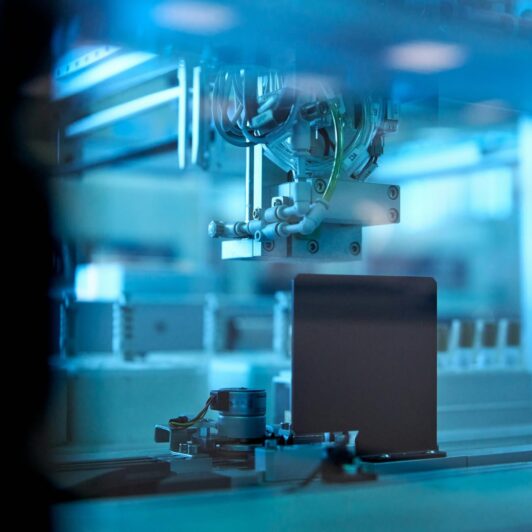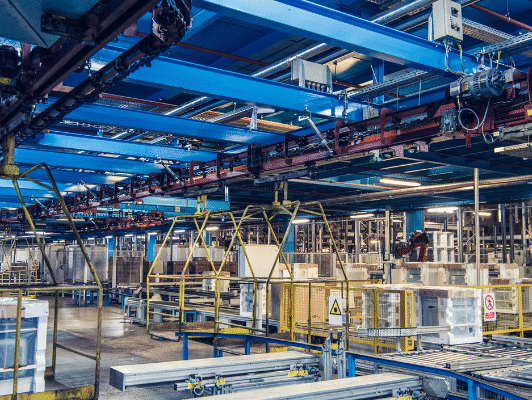
Autori
In questo articolo
Con il disegno di legge di bilancio per il 2026 il Governo opera una significativa inversione di rotta per le politiche italiane di sostegno all’innovazione industriale. Dopo la lunga stagione dei crediti d’imposta, culminata con le ultime, complesse vicende dei piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0, il governo pianifica per il 2026 un ritorno al meccanismo della maggiorazione degli ammortamenti. E lo fa cogliendo un po’ tutti di sorpresa con una misura unica per la doppia transizione digitale e green, finanziata da risorse nazionali e molto interessante grazie alle generose aliquote previste.
La scelta del Governo chiude quindi (con una piccola eccezione che vedremo dopo) il capitolo dei crediti d’imposta a sostegno degli investimenti 4.0 e 5.0, introdotto nel 2020, che puntavano sul sostegno della liquidità (i crediti si recuperavano molto velocemente) per aprirne uno nuovo fondato sulla più tradizionale leva fiscale della deduzione fiscale, con tutti i pro e i contro del caso, tra cui l’oggettiva impossibilità, per le aziende agricole che determinano il reddito con il criterio catastale, di fruire dei nuovi incentivi.
Di qui l’eccezione cui accennavamo prima: un nuovo credito d’imposta per l’Agricoltura 4.0. La vedremo più avanti.
Ma, a proposito di crediti d’imposta, la legge di bilancio introduce anche un’altra, importantissima norma, contenuta nell’articolo 26, che limita fortemente le modalità di compensazione dei crediti d’imposta (è una norma generale che varrà anche per gli attuali piani Transizione 4.0 e 5.0), andando a complicare le scelte delle aziende di questa fine d’anno.
Come funziona il nuovo iperammortamento 2026
Come anticipato, la misura principale della manovra 2026 abbandona la logica dei crediti d’imposta per tornare alla maggiorazione del costo di acquisizione (iperammortamento) dei beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati (allegati A e B, che forse saranno aggiornati) e dei beni strumentali per l’autoproduzione di energia. Si tratta di un meccanismo ben noto alle imprese: una “variazione in diminuzione” del reddito imponibile, spalmata su più anni in base alla durata dell’ammortamento del bene strumentale, generalmente compresa tra i 3 e i 10 anni.
Le aliquote previste sono decisamente generose. Il disegno di legge di bilancio (che, a scanso di equivoci, ricordiamo dovrà percorrere l’iter di approvazione in parlamento e potrà essere modificato prima della promulgazione che avverrà, come di consueto, tra il 30 e il 31 dicembre 2025) prevede maggiorazioni differenziate sia per soglie di investimento sia a seconda che l’investimento consegua o meno un target di risparmio energetico (una riduzione del 3% dei consumi dell’unità produttiva o del 5% del processo produttivo interessato dall’investimento).
Aliquote base (Transizione 4.0):
- +180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- +50% per la fascia tra 10 e 20 milioni di euro.
Aliquote maggiorate (Transizione 5.0, +40% sulle precedenti):
- +220% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +140% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- +90% per la fascia tra 10 e 20 milioni di euro.
Accedono de jure alle aliquote maggiorate anche:
- gli investimenti in sostituzione di beni il cui ammortamento è terminato da almeno 24 mesi
- i progetti realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC che preveda l’ottenibìmento di quei target di efficientamento
- I pannelli solari con celle bi facciali con un’efficienza di cella almeno pari al 24%
Un aspetto fondamentale della nuova misura, che la differenzia nettamente dal Transizione 5.0 (finanziato con fondi PNRR), è la sua copertura finanziaria. Essendo finanziata interamente con risorse nazionali, la nuova maggiorazione non sarà soggetta ai complessi vincoli europei del “Do No Significant Harm” (DNSH).
Inoltre, non essendo vincolata ai fondi RepowerEU, non prevede le esclusioni settoriali (come quelle per le imprese operanti nei settori hard-to-abate o ad alta intensità energetica) che hanno caratterizzato il piano 5.0, rendendola accessibile a una platea molto più ampia di beneficiari.
Maggiorazione degli ammortamenti vs crediti d’imposta
Il passaggio dal credito d’imposta alla deduzione non è neutrale e presenta una serie di “pro e contro”.
Se il credito agiva come sconto diretto sulle imposte, l’ammortamento è una deduzione dal reddito imponibile.
Le differenze sono importanti. Il Credito d’imposta (come Transizione 4.0 e 5.0) punta sulla liquidità: è un credito fruibile in F24, rapidamente (spesso in 3 anni, o anche 1 per il 5.0) e, soprattutto, utilizzabile anche dale aziende con poco reddito imponibile. Di contro, si è dimostrato vulnerabile alle decisioni di cassa del Governo, come dimostra proprio il nuovo articolo 26 che vedremo dopo.
L’Iperammortamento (modello 2026) punta sulla deduzione: il suo vantaggio è la relativa semplicità burocratica (per l’accesso alla maggiorazione di base) e la certezza fiscale (non dipende da tetti di compensazione mensili). Di contro, il suo svantaggio principale è che serve appunto “capienza” IRES per poterlo monetizzare: è una deduzione, quindi se l’impresa non genera utili imponibili sarà una perdita fiscale riportabile a nuovo. Il beneficio fiscale, poi, anche in caso di capienza fiscale si spalma su tutto il lungo periodo di ammortamento del bene (es. 5, 7 o 10 anni), impattando molto più lentamente sulla cassa.
Resta però il dubbio strategico per le aziende: gli investimenti pianificati per fine 2025, che potrebbero ancora godere (teoricamente) della Transizione 5.0, saranno più o meno convenienti di quelli posticipati al 2026? Ne parleremo alla fine dell’articolo.
L’eccezione per l’Agricoltura 4.0
Ed ecco l’eccezione menzionata in apertura. Dato che le aziende agricole che determinano il reddito su base catastale non possono beneficiare di una deduzione fiscale dal reddito d’impresa (come l’iperammortamento), il governo ha previsto per loro uno strumento ad hoc.
Per il 2026 viene istituito un credito d’imposta specifico, con un’aliquota unica e particolarmente elevata: il 40% delle spese sostenute per investimenti in tecnologie 4.0 applicate al settore primario (agricoltura di precisione, sensoristica, droni, ecc.) con con un tetto massimo di spesa ammissibile fissato a 1 milione di euro.
Attenzione però: se l’aliquota è indubbiamente attrattiva, la normativa è piuttosto oscura su un punto non secondario. Si menziona, infatti, un limite complessivo di 2,1 milioni che non è chiaro se sia riferito – ma sarebbe clamoroso – alla dotazione complessiva di fondi per la misura oppure, più probabilmente ma piuttosto incomprensibilmente, al tetto complessivo per impresa: in pratica si supererebbe il limite di 1 milione prefigurando la possibilità di effettuare più tornate consecutive di investimenti, fino a 1 milione l’una e fino al limite complessivo di 2,1 milioni.
Come cambiano le compensazioni dei crediti d’imposta: l’impatto dell’articolo 26
E veniamo all’articolo 26 del disegno di legge di bilancio che potrebbe – se confermato – avere un impatto devastante sui residui crediti d’imposta: non solo questo appena visto, ma anche quelli legati alla ZES unica e ad altre misure di incentivazione. E che complicherebbe anche le scelte di fine anno delle aziende.
La norma prevista dall’articolo 26 interviene sulle modalità di compensazione di tutti i crediti d’imposta per investimenti. La disposizione impone limiti molto stringenti all’utilizzo in F24 dei crediti maturati e prevede che “I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione […] ai fini del pagamento dei debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo decreto.”
Il divieto riguarda cioè i contributi previdenziali INPS, i premi assicurativi INAIL, sanzioni e interessi su tributi e contributi e altre entrate patrimoniali dello Stato (canoni demaniali, concessioni, diritti camerali).
Si tratta di una misura che rischia di “congelare” la liquidità che le imprese si aspettavano di recuperare rapidamente.
Il dilemma di fine anno
Qui si innesta il “grande dilemma” per le aziende che si trovano a fine 2025. I “vecchi” piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 sono ancora in vigore per gli investimenti effettuati fino a fine anno. Nel caso di Transizione 4.0, che offre un credito d’imposta del 20%, le imprese hanno tempo fino al 31 dicembre per “prenotare” l’incentivo (versando un acconto minimo del 20%). Nel caso del 5.0 invece entro il 31/12 devono essere completati gli investimenti, eccezion fatta per l’interconnessione e l’allacciamento alla rete, mentre per ultimare le pratiche il termine è il 28/2. Le aliquote, come sappiamo, arrivano fino al 45%, a patto di conseguire un risparmio energetico.
Questa scelta potrebbe essere preferita da chi desideri sfruttare il sistema dei crediti d’imposta per velocizzare il rientro dell’investimento. Ma l’articolo 26 cambierebbe drasticamente le carte in tavola. Un’azienda che realizza oggi un investimento significativo contando su un credito d’imposta 5.0 che non riesce a recuperare entro il 2025, dovrebbe spalmarlo, come già prevede la normativa, nei cinque anni successivi a quote costanti, scoprendo magari di non poterlo compensare sui versamenti degli oneri previdenziali, perdendo gran parte del beneficio finanziario immediato.
Cosa fare, dunque? Attendere il 2026 per un iperammortamento più semplice e attraente ma fiscalmente meno “liquido”? O accelerare per chiudere gli ordini 5.0 entro il 31 dicembre, accettando la complessità delle certificazioni e, soprattutto, il nuovo e stringente vincolo di liquidità imposto dall’articolo 26?
Non esiste una risposta unica. Avvalersi della competenza di un partner specializzato è il consiglio migliore che possa darvi.